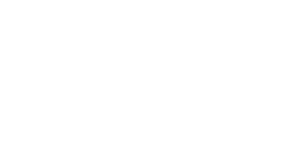«Ho sempre pensato che l’Onu abbia un enorme potenziale ma che, al momento, non lo stia realizzando. Per molto tempo è stata inefficace. Ci sono grandi speranze, ma, ad essere onesti, non è ben gestita». Con queste parole, a pochi minuti dall’incontro col primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha formalizzato il ritiro dal Consiglio per i diritti umani (Unhrc) e dalla principale agenzia di soccorso Onu per i palestinesi (Unrwa).
Tutt’altro che isolato, l’ordine esecutivo firmato da Trump richiede al segretario di Stato americano di rivedere e riferire quali organizzazioni, convenzioni o trattati internazionali promuovono «sentimenti radicali o anti-statunitensi». Una «revisione accelerata» è stata richiesta per l’organizzazione per l’Educazione, la scienza e la cultura (Unesco), mentre già nel giorno del suo insediamento Trump aveva firmato un ordine esecutivo per il ritiro dall’organizzazione mondiale della Sanità perché «l’Oms continua a chiedere agli Usa pagamenti di gran lunga sproporzionati rispetto a quelli di altri Paesi».
Ancora una volta, Trump intende così ergersi a interprete del sentimento popolare americano antiglobalista, secondo cui la presenza degli Stati Uniti nel mondo va ridimensionata perché sovraestesa e troppo costosa. Il senso del motto “America first” sta tutto qui. E se da un lato richiede di concentrare sforzi e risorse sul fronte interno, dall’altro impone però a Washington di porgersi una domanda: come cambierà il modo in cui gli Stati Uniti si relazionano col mondo?
Dilemma non facilmente risolvibile perché ad aver plasmato il modello su cui si basa oggi il multilateralismo sono stati proprio gli Stati Uniti. Esposto a Versailles sotto la ventottesima presidenza di Thomas Woodrow Wilson attraverso i 14 punti che avrebbero dovuto guidare l’ordine mondiale nel primo dopoguerra, attuato solo nel 1944 con gli accordi di Bretton Woods e nel 1945 con l’istituzione delle Nazioni Unite, infine alimentato dalla globalizzazione quindi da un mondo privo di barriere e basato sul libero commercio, il modello internazionalista è oggi contestato da buona parte della società americana per varie ragioni.
Innanzitutto, perché ha imposto agli Stati Uniti di non darsi alcun limite geografico e di confermare la sua presenza in molteplici teatri — dalla Corea al Vietnam fino all’Afghanistan e all’Iraq, cui vanno aggiunti i soldati in Germania, Italia e Giappone oppure il supporto militare a Ucraina e Israele. Oltre a richiedere notevoli costi e impegni, la sovraestensione ha però generato malcontento e sofferenze a livello interno. Perché, mentre la classe dirigente americana guardava al mondo, la classe media statunitense ha visto diminuire il suo tenore di vita, ha dovuto fare i conti con la concorrenza a livello internazionale — favorita proprio dalla globalizzazione —, con gli alti costi di produzione e con la disoccupazione — basti pensare al Midwest. Di conseguenza, si è sentita dimenticata ed è diventata più violenta, incapace d’incontrarsi e di comunicare.
A ciò bisogna poi aggiungere il cambiamento d’epoca di fronte al quale ci troviamo: il mondo è diventato più conflittuale e frammentato. Di fronte all’emergere di molti sfidanti dell’egemonia americana, promuovere una visione internazionalista è oggi difficile, ancor più perché la politica riflette la difficoltà della società a dialogare e a trovare compromessi.
Donald Trump ha vinto non solo cavalcando il malcontento interno, bensì proponendo un’alternativa al modello globalista basata sul principio del destino manifesto. Lo slogan «make America great again» impone di «far tornare gli Stati Uniti all’età dell’oro» e, per farlo, richiede un maggior protagonismo americano in quanto nazione, non in quanto rappresentante del multilateralismo. Essendo frutto di un sentimento popolare, è probabile che Trump abbia solo inaugurato la nuova strategia americana e che in futuro altre figure la porteranno avanti. In ogni caso, un cambiamento del genere richiede a tutte le altre potenze — quelle europee in primis — di stabilire come relazionarsi con gli Stati Uniti e col mondo che verrà.
L’Osservatore Romano – 05/02/2025