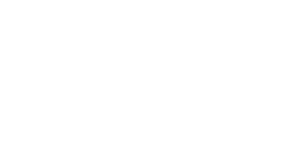Lo scorso lunedì, il 20 gennaio, mentre il neopresidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dichiarava di voler «mettere l’America al primo posto» in occasione del suo discorso inaugurale, il ministero degli Esteri cinese annunciava di aver mediato con successo un accordo di cessate-il-fuoco tra il Myanmar National Democratic Alliance Army (Mndaa) e la giunta militare birmana. Una coincidenza solo in apparenza casuale, che anzi rivela un profondo aspetto geopolitico: il modo attraverso cui le grandi potenze si proiettano nel mondo sta cambiando e, di riflesso, sta mutando il modo in cui le grandi potenze vengono percepite.
La crisi in Myanmar lo dimostra. Divenuto provincia dell’India britannica dopo le guerre anglo-birmane del 1824-1886, invaso dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale, indipendente dal 1948, per il resto dello scorso secolo dilaniato dal conflitto tra il generale Ne Win e i nemici della dittatura, il Myanmar viene visitato da un esponente di spicco del governo statunitense solo nel dicembre 2011. In quell’occasione, l’ex segretario di Stato americano, Hillary Clinton, incontra il presidente Thein Sein e la leader dell’opposizione Daw Aung San Suu Kyi, la cui Lega nazionale per la democrazia è stata ammessa alle elezioni parlamentari del 2012.
Un risultato storico, se si pensa che il partito di Aung San si presenta alle prime elezioni libere datate 1990 e, seppur vincendo, viene spodestato dal Consiglio di restaurazione della legge e dell’ordine di Stato, supportato dall’esercito nazionale. Aung viene arrestata tre volte e liberata solo nel 2010 quando, a causa delle molteplici sanzioni internazionali, il referendum costituzionale e le elezioni in Myanmar aprono le porte al cambiamento. Che diventerà concreto nel 2015: il partito di Aung vince le elezioni e la leader democratica diventa ministro degli Esteri e consigliere di Stato.
Anche se la missione americana è orientata alla strategia di Barack Obama “Pivot to Asia”, volta ad incrementare i rapporti con i Paesi del gruppo Asean e ad accerchiare la Cina, Hillary Clinton, nel cuore della campagna presidenziale contro Trump, rivendica il successo delle elezioni birmane, «un importante, seppur imperfetto, passo avanti verso la democrazia». E, in pieno stile globalista, rimarca il «ruolo indispensabile che gli Stati Uniti possono e devono svolgere nel mondo come campioni di pace e progresso».
Sei anni dopo, il mondo è nel pieno di un cambiamento epocale e, con esso, lo è anche il Myanmar. Mentre il Covid-19 divampa ovunque e il modello americano di Trump si scontra con il progresso targato Cina, sul viale principale della capitale del Myanmar un’insegnante di aerobica che pubblica i propri video su Facebook viene circondata dall’esercito nazionale. Le immagini fanno presto il giro del mondo. Inizia così, il primo febbraio 2021, il golpe in Myanmar. Le Nazioni Unite si riuniscono per condannare l’atto e firmare una risoluzione in cui si chiede il «ripristino della democrazia» che, però, non viene adottata. Cina e Russia, membri permanenti del consiglio di Sicurezza Onu con potere di veto, sono contrari.
In particolare, la Cina condivide col Myanmar oltre duemila chilometri di confine e ne è principale partner economico, con un commercio bilaterale pari ad almeno dieci miliardi di dollari. Ma, soprattutto, il corridoio Cina-Myanmar, insieme ai suoi piani infrastrutturali fatti di trasporti stradali e ferroviari fino alla città portuale di Kyaukpyu, permette a Pechino di arrivare all’Oceano Indiano senza passare per lo stretto di Malacca, collo di bottiglia lungo 800 chilometri su cui transita buona parte del commercio mondiale ma su cui veglia la marina statunitense. Come se non bastasse, il Myanmar è ricco di materie prime come barite, stagno, tungsteno, oro, argento, piombo e zinco, necessarie ad alimentare batterie elettriche o pannelli solari e a sviluppare smartphone o servizi di intelligenza artificiale, quindi a realizzare la transizione energetica e lo sviluppo tecnologico di cui Pechino vuole farsi rappresentante.
Per tutelare i suoi interessi e garantire la stabilità al confine, anziché passare per i canali Onu, la Cina negli anni ha preferito mediare tra gli attori in campo, dialogando tanto con l’esercito nazionale quanto con i ribelli. E, così, è riuscita ad arrivare al cessate-il-fuoco dello scorso 20 gennaio. Un messaggio importante da mandare in primis al gruppo Asean che, spaventato dall’«America first» di Trump e intimorito dalle rivendicazioni territoriali della Cina, nell’ultimo vertice di novembre aveva dato priorità alla «pace in Myanmar». Un risultato cui Pechino ambisce sempre più, sia per interessi interni sia per ambizioni esterne, specie nel momento in cui Washington sta rivalutando la sua proiezione nel mondo.
L’Osservatore Romano – 31/1/2025