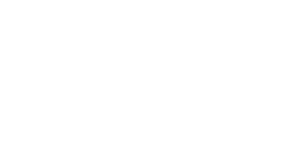Che sia un modo per allinearsi alla nuova presidenza repubblicana di Donald Trump e alla figura di Elon Musk, è piuttosto chiaro. Ma la scelta di Mark Zuckerberg di modificare le politiche di moderazione dei contenuti sulle piattaforme Meta e, negli Stati Uniti, di interrompere il programma introdotto otto anni fa per arginare la circolazione di notizie false su Facebook e Instagram, va ben oltre. E dice molto sulla situazione culturale e sociale entro cui si trovano gli Stati Uniti a pochi giorni dall’insediamento del quarantasettesimo presidente.
Un Paese alle prese con una società sempre più disconnessa, dove i luoghi di raduno comunitario si stanno svuotando — basti pensare alle Chiese protestanti o ai sindacati —, le occasioni di partecipazione civica si vanno riducendo e i quotidiani di informazione locale chiudono. Una situazione ancor più amara per chi vive lontano dalle coste e appartiene alla ormai decadente classe media, quella che un tempo veniva definita la working class formata, almeno secondo l’immaginario collettivo occidentale, da operai con la villetta a schiera, il giardino col barbecue e il garage con la Ford.
Oggi quel tipo di cittadino americano stenta ad esistere e, se esiste, si ritrova spesso solo, sfornito dei punti di riferimento sociali entro i quali è cresciuto, deluso dall’idea della globalizzazione che anziché rafforzare la proiezione americana nel mondo ha aumentato la competitività e ha contribuito alla chiusura delle fabbriche meno efficienti, spesso alle prese con una crisi economica quantomeno percepita e quindi con un certo disagio sociale.
Di conseguenza, gli americani dialogano di meno, s’incontrano di meno, scendono meno a compromessi. E, così, continuano a trovare nei social network l’unico luogo adatto a incontrarsi e a far veicolare informazioni e idee di ogni tipo. Dal supporto a Luigi Mangione, accusato dell’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato dell’azienda di assicurazioni mediche UnitedHealthcare, alle teorie complottiste riguardanti elezioni, migranti, costo della vita. Qui la regola è una sola: radunarsi tra chi ha le stesse opinioni senza sentirsi giudicati e senza porre alcun freno alla circolazione dei propri pensieri o delle notizie. Non conta chi veicola certe informazioni o come esse vengono veicolate. L’importante è racimolare fatti e testimonianze che rafforzino le proprie convinzioni e deridano chi la pensa in modo diverso, con cui non bisogna neppure confrontarsi. Vale per i conservatori così come per chi incarna il pensiero woke, ossia i fanatici della libertà senza alcuna responsabilità.
Fondata su radici antropologiche, alimentata dall’odio verso il prossimo che la pensa in modo diverso e dall’insoddisfazione personale, questa regola non si ferma al perimetro immateriale della tecnologia, bensì produce conseguenze geografiche. Mentre liberal e conservatori si spostano verso zone ritenute più affini al loro pensiero, cresce la difficoltà di trovare dei veri swing states: ormai molti americani decidono dove vivere perché sanno che in una certa contea o in una certa città dominano i repubblicani o i democratici e, così, sempre più Stati stanno diventando regimi a partito unico privi di alcuna opposizione.
Ecco perché l’iniziativa di Zuckerberg diventa tanto preoccupante quanto rappresentativa dell’anima americana contemporanea. La novità non sta nel fatto che un grande imprenditore si sia allineato alla figura presidenziale appena eletta. Storicamente ciò è sempre avvenuto. Anzi, avviene ancor più oggi, alla luce degli innumerevoli successi che Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg stanno ottenendo su mercati fondamentali, dalla tecnologia all’intelligenza artificiale fino all’automotive e allo spazio. Peraltro, è difficile credere che fino ad ora il fact checking su Meta abbia davvero funzionato: quante notizie false sono comunque veicolate nonostante i tanto vituperati controlli e le segnalazioni? Quanti insulti? Quanta disinformazione?
La scelta di Meta va quindi letta entro un’altra dimensione. Anche per scopi economici, Zuckerberg intende far capire agli americani che, in base al loro disagio antropologico e sociale, nelle sue piattaforme possono trovare tutta la libertà e lo spazio di cui hanno bisogno per sfogarsi e animare le proprie idee. Nessuno potrà bandire i contenuti o etichettarli come disinformativi, a meno che non siano segnalati dagli altri utenti. Proprio come avviene sulla piattaforma «X», un tempo «Twitter», da quando è stata acquisita da Elon Musk. Col rischio, altamente probabile, di far diventare l’America ancora più disconnessa, polarizzata, incapace di dialogare e di scendere a compromessi persino coi propri familiari. Col rischio, insomma, di alimentare il caos.
L’Osservatore Romano – 17/01/2025