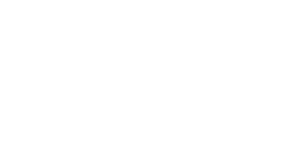Proprio nell’anno in cui prevedeva di diventare leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici, il colosso tedesco Volkswagen si ritrova nella situazione opposta: lo scorso agosto ha annunciato la prima storica chiusura di tre stabilimenti in Germania, poi si è vista costretta a ritirarla dopo mesi di scioperi e minacce da parte dei propri dipendenti. Le sue auto costano troppo, il gradimento dei consumatori nei confronti della nuova tecnologia è stato inferiore alle attese e, non ultimo, la concorrenza dei produttori cinesi — sul fronte dei prezzi e della qualità — ha messo in crisi l’intero settore dell’automotive, architrave dell’industria europea poiché impiega dieci milioni di lavoratori e rappresenta oltre il 7 per cento del pil dell’Unione europea.
Come è potuto succedere? Tutto comincia nel 2015, anno in cui lo scandalo del “Dieselgate” fa emergere che Volkswagen ha manipolato i risultati delle emissioni dei propri veicoli diesel, facendoli risultare molto meno inquinanti rispetto alla realtà. La Germania si sente colpita nel cuore: la soluzione brevettata negli anni Settanta per rispondere sia alla presa di coscienza sulla tematica ambientale sia alla crisi petrolifera si è dimostrata un boomerang, almeno secondo l’agenzia per la protezione ambientale degli Usa. Per riconquistare fiducia nei confronti dei consumatori e delle istituzioni, ergendosi a modello per il mondo intero, governo e aziende tedesche — attraverso l’Ue, in particolare la Commissione — promuovono il motore elettrico come unica alternativa adatta tanto a salvaguardare l’ambiente quanto a innovare il modello di business.
Nel farlo, si dimostrano però non solo incapaci di dettare strategie, di analizzare costi e benefici di una transizione, di conoscere i gusti dei consumatori, ma persino di fare i conti. Innanzitutto, i tedeschi hanno sottovalutato la Repubblica Popolare Cinese, considerandola solo come un mercato in cui produrre a bassi costi grazie alla grande disponibilità di manodopera e in cui vendere prodotti a oltre un miliardo di consumatori.
Piuttosto, i cinesi hanno osservato, copiato e rinnovato il lavoro degli occidentali grazie alle joint ventures avviate proprio dalla Germania in Cina negli anni Ottanta. Dopo l’ingresso nell’organizzazione mondiale del Commercio datato 2001, grazie a una politica industriale mirata, disposta a spendere tanto e a sacrificare imprese modeste a fronte dei grandi gruppi, aiutata dall’ampia disponibilità di materie prime, Pechino già nel 2009 vara un piano per rivitalizzare l’industria automobilistica. Colossi nazionali come Byd e Catl comprendono presto la necessità di costruire veicoli non solo elettrici ma pure elettronici, cioè dotati della migliore tecnologia disponibile, e così convincono i consumatori locali al cambiamento. I risultati sono strabilianti: i cinesi hanno raggiunto il target di vendere almeno il 50 per cento di auto elettriche con dieci anni d’anticipo e Byd ha superato Tesla nelle esportazioni mondiali di auto.
Al contrario, l’Ue è l’unica, insieme alla California, ad aver imposto un limite completo alla produzione di auto endotermiche dal 2035, ma sta più indietro di tutti. Perché, oltre a non aver colto la sfida tecnologica e ad aver sottovalutato attori emergenti, non si è posta il problema di come reperire le materie prime necessarie a costruire un’auto elettrica —litio, nichel e cobalto, la cui lavorazione è peraltro altamente inquinante —, detenute in larga parte da Paesi come Cina, Vietnam, Indonesia, Cile o Brasile. Non solo: l’energia elettrica con cui si alimenta una batteria non è una fonte ma un vettore, perciò dev’essere prodotta, ma le rinnovabili non bastano e spesso si fa affidamento al gas o al carbone, come in Cina, dove il costo dell’energia è però molto più basso rispetto all’Europa.
Nonostante ciò, a Berlino come a Bruxelles si è voluto puntare tutto solo sull’elettrico, tralasciando ancora una volta il rischio di fare affidamento ad un’unica soluzione e, quindi, sottovalutando il concetto di neutralità tecnologica. Che, per rispettare i tempi e i mezzi di un processo definito transizione, basato quindi sulla gradualità e su una serie di processi di adattamento, avrebbe dovuto invece coinvolgere altre soluzioni che esistono e sono meno costose per i consumatori come per i produttori, dalla benzina verde ai biocarburanti.
La rigidità con cui l’Ue rifiuta queste alternative, se non attraverso piccole deroghe, è confermata dalle multe in vigore da quest’anno: paradossalmente, il vero motivo per cui i gruppi automobilistici intendono chiudere gli stabilimenti è evitare di produrre auto endotermiche che, emettendo quantità di Co2, li costringerebbero a pagare miliardi di euro di multe, stabilite di comune accordo da istituzioni e aziende europee anni fa, quando manager e politici di alta classe erano impegnati a promuovere la fantomatica rivoluzione verde. Il caos sociale e politico in Germania, che ha portato a un’inedita crisi di governo e a una crescita esponenziale dei partiti estremisti, si spiega anche così.
L’Osservatore Romano – 10/01/2024