«Il modello economico internazionale sancito dagli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale ha fallito» perciò «è necessario costruire un nuovo Washington consensus». Il recente discorso di Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Joe Biden, è chiaro: checché se ne dica, la globalizzazione non è finita e gli Stati Uniti sono almeno parzialmente responsabili di come si trasformerà questo processo.
Tuttavia, proprio su questi aspetti la politica americana è più che mai divisa: attuare misure protezioniste per valorizzare l’industria nazionale o coinvolgere i paesi alleati per costituire un unico blocco? Isolare Pechino o riconoscerne la centralità in mercati come quello delle materie prime, scendendo a patti? De-globalizzazione o ri-globalizzazione?
Nei giorni scorsi la Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana e il Senato a maggioranza democratica hanno votato a favore del ripristino di dazi fino al 254 per cento sui pannelli solari provenienti dal sud-est asiatico. I politici statunitensi affermano che, per aggirare le sanzioni, la Cina avrebbe spostato la produzione in Paesi come Cambogia, Malaysia, Thailandia e Vietnam. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), nel 2021 gli Usa erano responsabili del 17 per cento della produzione globale di energia solare, ben lontani dal 38 per cento della Cina.
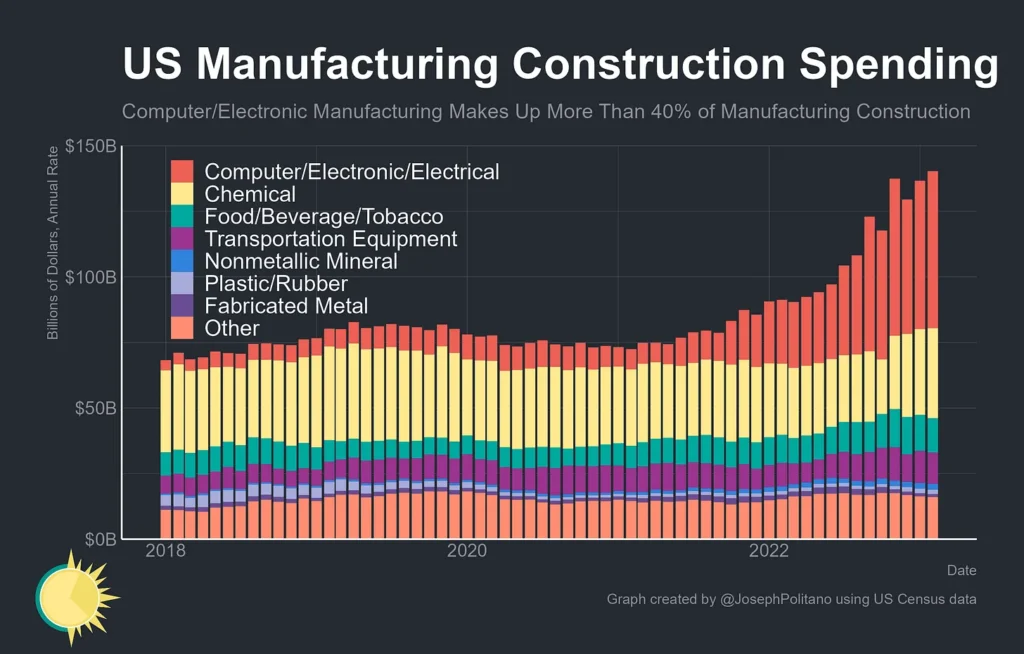
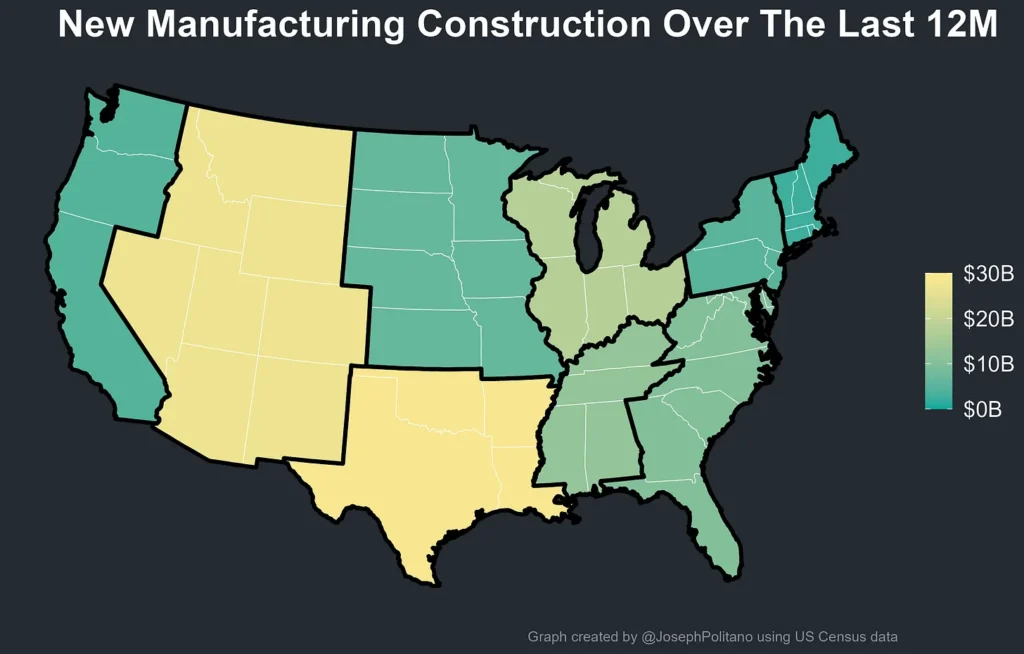
Ma le intenzioni della Casa Bianca non paiono le stesse. Citando Sullivan, l’obiettivo per un «ordine economico globale più equo» è sì basato sull’isolamento della Cina e su una moderna strategia industriale americana, ma soprattutto sull’espansione oltre i confini nazionali. I quattro Paesi del sud-est asiatico fungono da esempio. Affacciano sul Pacifico, detengono materie prime e manodopera a basso costo, basti pensare ad Apple in Vietnam. Garantiscono, pertanto, prezzi più bassi, importanti con un’inflazione ancora alta, e accesso all’industria energetica, funzionale alla lotta al cambiamento climatico. Perciò, a giugno 2022, Biden aveva deciso di interrompere per due anni ogni forma di dazio contro i quattro paesi in questione.
Al di là della misura legislativa e dell’idea di globalizzazione, il messaggio politico è chiaro: non tutti gli americani vogliono impegnarsi nel mondo. Il bipolarismo è finito, i rischi sono tanti e gli impegni assunti troppi. Washington guarda al Pacifico (quindi Taiwan, Australia, Giappone, Corea del Sud, Filippine, India) e all’Europa (guerra in Ucraina, Regno Unito, est Europa ed Europa occidentale). Peraltro, non tutti gli alleati sembrano convinti di sapere da quale parte stare.

Molteplicità degli attori e complessità delle posizioni rivelano una crisi interna all’identità americana e un dibattito che non può rimanere confinato agli Stati Uniti. Ancora più se le alternative sono due: chiudersi o dividere. Papa Francesco lo ha ribadito spesso: distinguere il mondo in blocchi geopolitici non solo è oggi più complesso, ma anche meno conveniente per tutti. La transizione energetica occidentale, ad esempio, sembra irraggiungibile in tempi brevi e costi contenuti senza le materie prime dall’Asia. Troppi Paesi rischierebbero di essere isolati o sfruttati: si pensi al continente africano, all’India, il più popoloso al mondo ma con una povertà assai diffusa. Un mondo sanzionato sarebbe un mondo che non si parla e non s’incontra neanche su temi come i diritti umani. E globalizzazione — che è sempre esistita ma in forme diverse — non significa ormai solo commercio. Ma dati, finanza, tecnologia, turismo, culture, comunicazione. Annullare o riformulare, dunque, ma a costo di rinunciare.
L’Osservatore Romano – 16/5/2023

