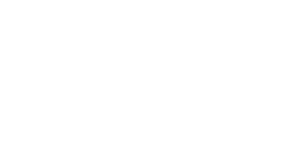Che fine ha fatto il sogno europeo. Il tema trae facilmente spunto dalle cronache di un’Europa schiacciata dall’impeto delle grandi potenze e ridotta a un apparato burocratico che fatica a conquistare i cuori. Certo, dopo decenni abbiamo un’unione economia e monetaria, una moneta unica, un parlamento, abbiamo persino la cittadinanza europea. Eppure, sembra mancare qualcosa cui forse, secondo alcuni, non si potrà mai porre rimedio: noi, giovani, adulti, italiani, tedeschi, lituani, ungheresi, ci sentiamo davvero europei? E come è evoluto questo sentimento nel corso degli anni? Lo chiamiamo sogno, dovremmo definirlo incubo oppure addirittura qualcosa cui non pensiamo?
Sono le domande che abbiamo posto al centro di un dialogo fra un adulto, Giorgio Dell’Arti, giornalista e storico italiano, direttore di “Anteprima – La spremuta dei giornali”, e un giovane, Cristiano Rimessi, collaboratore presso il think tank Parabellum e presso l’ufficio sviluppo internazionale dell’università Luiss Guido Carli di Roma. «Chiariamo subito che io non sono un adulto, sono un vecchio — esordisce Dell’Arti — ma questo ai fini del confronto generazionale è un bene: io sono un quasi ottantenne mentre Cristiano ha 28 anni. Alla sua età, Napoleone era generale e aveva già bombardato Tolone. Personaggio controverso, sì, ma Napoleone l’Europa l’aveva unita. Non è stato l’unico: l’unione più importante è stata quella della Chiesa. La parola cattolico vuol dire questo: c’è un’unione che si riconosce nel pontefice, in un sistema universale, in una sequenza di valori estremamente importanti per i quali tanti hanno dato la vita. In un certo senso, quello che forse manca all’Europa è proprio una condivisione di valori sentimentali, di quelle cose che ti fanno venire le lacrime agli occhi, per cui ci si sente partecipi di una comunità. Ma non dobbiamo avere fretta. Certi processi sono lunghi, complessi e forse quello che sta succedendo sul piano internazionale aiuterà al raggiungimento di un’identità comune».
Cristiano non è così fiducioso, anzi osserva come «la possibilità che ciò avvenga è molto difficile. Parlando ad esempio della guerra in Ucraina, giovedì c’è stato l’ennesimo vertice della coalizione dei “volenterosi”, che peraltro ora hanno pure cambiato nome diventando i “rassicuratori”. L’unica cosa che emerge è una volontà abbastanza generale di aiutare l’Ucraina, però manca il tassello più importante: come? Il tipo di aiuto cambia il dibattito. E svela il bluff. Gli europei sono ancora divisi su tematiche chiave e questo pone problematicità alla questione non indifferenti. Tuttavia, penso che proprio dalla Chiesa l’Europa possa imparare qualcosa: la capacità di diventare attrattiva. L’Europa non funziona perché non si sa vendere. I giovani non ci pensano e neanche ne parlano non solo per l’alto livello di individualismo e di disillusione che oggi regna sovrano, ma perché in Europa non c’è alcuna capacità di saper diffondere un’idea, un sogno, un messaggio da parte di queste istituzioni verticistiche. Non abbiamo neanche una squadra di calcio unica da schierare contro gli Stati Uniti. Ci facciamo la competizione tra noi stessi. La Chiesa, invece, con la parola di Dio ha convinto e convince».
«Ma lo ha fatto — replica Dell’Arti — perché qualcuno si è sacrificato. Cioè, la capacità di persuasione della Chiesa nasce con l’immenso sacrificio di Cristo che si è fatto crocifiggere. All’Europa questa testimonianza di sangue, di martirio, manca. Non è stata sufficiente neanche la Seconda guerra mondiale. Abbiamo partorito testi come il tanto dibattuto Manifesto di Ventotene, abbiamo avuto Alcide De Gasperi, Robert Schumann, Konrad Adenauer o Jean Monnet, la comunità del carbone e dell’acciaio, ma tutto ciò è sempre avvenuto al vertice, di cui non importava niente a nessuno. Ve lo dico da cronista di quegli anni: i giornali che raccontavano le riunioni a Bruxelles o i verbali dell’Atto Unico Europeo sono di una noia pazzesca. Di fronte ai testi sacri dell’Europa, noi caschiamo per terra dal sonno. Invece il Vangelo ha una forza letteraria, persuasiva e sentimentale invincibile. Seduce, conquista, vivifica. Smuove i cuori. Questo in Europa non avviene. E non avviene perché l’Europa è tutta burocratica, è concepita da signori che sono sempre stati al vertice, che non sanno come sono fatte le periferie né sanno come sporcarsi le mani».
Tuttavia, ben presto l’esercizio critico trova un freno sia in Giorgio Dell’Arti sia in Cristiano Rimessi ed entrambi, il “vecchio” e il “giovane”, concordano su un fatto: l’Europa sarà pure complicata, però esiste. Non solo: sopravvive. Ha sopravvissuto alle crisi finanziarie del 2008 e del 2012, alla pandemia nel 2020 e sta sopravvivendo alla guerra in Ucraina. Tutti la davano per spacciata. E se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump finisce per attaccarla definendola un “parassita” per l’economia americana, significa che l’Europa ha la sua forza. Ecco perché, prosegue Dell’Arti «noi dobbiamo difendere l’Europa continuando a criticarla, che è il miglior modo per difenderla. Abbiamo avuto ottant’anni di pace. Non possiamo dimenticarlo né trascurarlo. Affinché ciò avvenga, dobbiamo però acquisire un altro concetto che la Chiesa ha molto chiaro: l’Europa non è il centro del mondo. Non lo siamo geograficamente né tanto meno demograficamente». La relatività della nostra presenza sul pianeta deve far parte dell’ideologia dei valori europei. E forse potrebbe essere proprio questo il primo dei tanti tasselli per costruire un sogno europeo, di fronte al quale generazioni diverse non sono poi così lontane.
L’Osservatore Romano – 29/3/2025