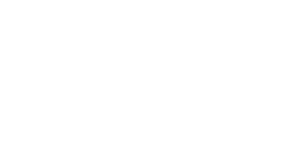Grafite, manganese, titanio, litio, uranio, berillio, ferro, poi terre rare, depositi polimetallici e metalli non ferrosi: sono questi i materiali presenti in Ucraina l’oggetto dell’accordo tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, che verrà siglato venerdì a Washington.
Tali minerali sono necessari ad alimentare le batterie delle auto elettriche o le centrali nucleari, indispensabili per sostenere settori quali difesa, aerospazio, chimica e farmaceutica Nonostante in Ucraina si concentri circa il 5 per cento delle risorse minerarie mondiali, secondo l’edizione 2024 di World Mining Data, il Paese si colloca al quarantesimo posto tra i produttori mondiali. Kyiv spera che l’affidarsi agli Usa sia fonte di garanzia per migliorare i rapporti con la nuova amministrazione Trump e per avviare un impegno statunitense a lungo termine in materia di sicurezza.
Auspicio che Zelensky si è affrettato a cavalcare decidendo di recarsi personalmente a Washington — anche se il viaggio previsto per venerdì prossimo non è stato ancora confermato — ma che Donald Trump ha cercato di ridimensionare: «Vogliamo i nostri soldi indietro, i contribuenti americani riavranno i loro soldi indietro. Senza gli Usa, i nostri soldi e le apparecchiature militari, la guerra sarebbe finita in un periodo breve».
Parole forti ma che, se dette dal neo presidente repubblicano, non devono stupire. La maggior parte degli elettori di Trump ritiene che la presenza americana nel mondo sia sovraestesa, abbia prodotto danni strategici se non reputazionali — basti pensare ad Afghanistan e Iraq, ma pure al Vietnam — e abbia alimentato malumori interni perché, mentre la classe dirigente americana guardava al mondo, la classe media ha visto diminuire il suo tenore di vita, ha dovuto fare i conti con la concorrenza a livello internazionale e, di conseguenza, è diventata più violenta, incapace d’incontrarsi e di comunicare.
Per mettere in atto il suo manifesto per l’America, basato sull’inizio dell’età dell’oro e la fine del declino nazionale, Trump non intende però fare a meno dell’espansionismo e dell’eccezionalismo. Piuttosto, sta sfruttando l’impegno statunitense nel mondo per ottenere benefici economici, quindi sociali e politici. Lo vuole fare con l’Ucraina, ma si è detto disposto a farlo pure con la Russia.
Dopo la dichiarazione di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, secondo cui ci sono «vaste possibilità di cooperazione tra Washington e Mosca per l’estrazione di terre rare perché gli Usa ne hanno bisogno e la Russia ne ha a sufficienza», Trump ha detto che gli «piacerebbe acquistare minerali anche dal territorio russo», aggiungendo che, dopo Zelensky, vedrà «presto» anche il presidente russo, Vladimir Putin. Un’intesa con la Russia, ribadita in questi giorni in sede Onu, dove Washington si è astenuta dal votare una risoluzione che condannava Mosca per aver avviato la guerra contro l’Ucraina, è mirata soprattutto ad allentare i rapporti tra la coppia Russia-Cina — unica vera alternativa all’egemonia americana — e ad incrementare la capacità di dialogo delle grandi potenze in Medio Oriente, specie nel Golfo dove attori sempre più rilevanti come Emirati Arabi Uniti o Arabia Saudita continuano a confrontarsi sia col Cremlino sia con la Casa Bianca.
Il riverbero di simili stravolgimenti sembra essere così forte da allarmare persino la dormiente Europa. Dopo il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer si è recato oggi in visita da Trump e ha annunciato — insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa — un vertice tra leader europei nel fine settimana in cui si proporrà di accelerare su un fronte duplice ma interconnesso, ossia quello del supporto all’Ucraina e quello delle capacità di difesa europee. Si parla di un fondo condiviso tra Unione europea (Ue) e Regno Unito per ipotetiche nuove spese militari. Sembra che le molteplici attenzioni riservate alle armi non siano date allo sviluppo di una capacità diplomatica e di dialogo comune, ipotesi ormai sempre più remota, specie per un attore tanto frammentato come l’Ue.
L’Osservatore Romano – 26/2/2025