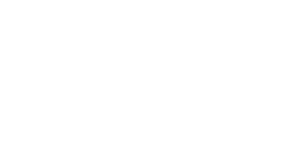Pierluigi Battista ha ragione. In un articolo dal titolo “La sera andavamo al cinema”, pubblicato lo scorso 8 febbraio sul quotidiano Il Foglio, ha scritto che «chi non ha vissuto il Novecento e si è spiritualmente formato nelle atmosfere del nuovo secolo forse non riuscirà nemmeno a immaginare cosa sono state le sale cinematografiche amate e frequentate dalle generazioni immediatamente precedenti».
Di più, a voler recuperare quello spirito, fatto di lunghe frotte di amici e familiari che si ritrovavano per incamminarsi verso il cinematografo, di nuvole di fumo che salivano verso il soffitto delle vecchie sale in cui era concesso fumare, di scricchiolii delle scomode sedie di legno, di maschere che, con uno charme tutto femminile, orientavano i ritardatari, insomma a voler recuperare tutto ciò che animava il “nuovo cinema paradiso”, oggi i giovani non ci pensano minimamente. E non solo perché i costumi sono cambiati e, da quando hanno inventato le videocassette, i film si vedono più spesso e più comodamente a casa, dove peraltro la tecnologia ha fatto enormi passi avanti, tra piattaforme streaming, spettacoli tridimensionali e schermi giganti.
Altrettanto sterile è la teoria secondo cui i cinema non esistono più. I cinema ci sono, a volte sono animati da feste e rassegne, alcuni sono dotati di schermi ipertecnologici e di impianti audio capaci di far vibrare corde dell’anima, altri sono vintage nelle dotazioni così come nelle programmazioni, altri ancora – soprattutto d’estate, all’aperto – registrano il tutto esaurito e sono capaci di generare dibattiti proprio come avveniva un tempo. Dal Cinema Troisi di Roma al Cinema ritrovato di Bologna, passando per l’AriAnteo di Milano, l’Arena di campo San Polo a Venezia o il Cinema in Piazza.
Nonostante ciò, quelle appena citate restano realtà isolate, imparagonabili a ciò che il cinema un tempo significava per un’intera società. Allo stesso modo, nonostante i potenti mezzi tecnologici a disposizione e la possibilità di sfogliare interi cataloghi cinematografici con un clic, tantissimi giovani non hanno alcuna intenzione di guardarsi un bel film, non trovano neppure il tempo di godersi un classico o un film d’autore che ha segnato la storia del cinema. Anzi, i film in bianco e nero li snobbano dato che, dicono in molti, “mi sanno di vecchio”. Si tapperebbe le orecchie il piccolo Totò, protagonista del “Nuovo cinema paradiso” di Giuseppe Tornatore, che, pur di collezionare più pellicole possibili, rischiava addirittura di bruciare la casa e la sorella.
Perché il problema per cui quello spirito sembra irrecuperabile sta proprio qui: nella perdita di curiosità che significa appiattimento dello stupore, mancanza di desiderio, totale adesione verso l’individualismo e disinteresse nei confronti dell’altro inteso come ciò che ci è estraneo o chi ci è vicino, quindi assenza di luoghi comunitari in cui incontrarsi. Cambiamenti antropologici con conseguenze sociologiche tuttora in atto che toccano in primis i giovani. I quali sono nati e cresciuti non solo senza cinematografo, ma pure senza associazioni studentesche, partecipazione politica, vita nelle parrocchie quindi negli oratori e nei cineclub, giochi per strada o nelle piazze. E, di riflesso, stanno perdendo la capacità di sognare. Come individui e come comunità.
Ecco perché un luogo come il nuovo cinema paradiso, oggi, non va più di moda. Quello non era un cinematografo qualsiasi. Era un luogo in cui poter arrivare a qualsiasi ora per guardare le storie degli altri e per discuterne, in cui accendere lo schermo per proiettare ogni bacio dato e celebrare tutte le promesse non mantenute, in cui far cessare ogni negatività prendendosi per mano e cercando una soluzione ai problemi, mai davvero isolati, in cui piangere, abbracciandosi, sulle note della colonna sonora della propria vita, in cui – avrebbe detto Philippe Noiret nei panni di Alfredo – «non farsi fottere dalla nostalgia». Forse proprio per questi stessi motivi è il luogo di cui tutti, specie noi giovani, avremmo bisogno. Ancor più oggi.
L’Osservatore Romano – 26/2/2025