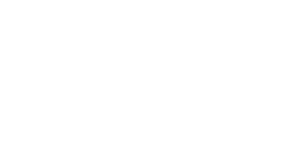Il summit straordinario voluto dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron per discutere il ruolo dei Paesi europei in negoziati di pace a tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina arriva in uno dei momenti più critici per il Vecchio Continente.
Innanzitutto, la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, svoltasi la scorsa settimana, sembra aver segnato la fine di un’epoca nell’alleanza con gli Stati Uniti. Tre indizi fanno una prova. Il primo: l’inviato statunitense per l’Ucraina, il generale Keith Kellogg, ha esplicitato agli alleati europei l’intenzione di escluderli dal tavolo dei colloqui tra Washington e Mosca previsti per domani a Doha, citando il precedente degli accordi di Minsk. Sono stati poi inediti i toni usati dal vicepresidente americano J.D. Vance il quale, dal palco di Monaco, ha ricordato agli europei che «la democrazia si basa sul sacro principio secondo cui la voce del popolo conta» e ha accusato l’Unione europea di aver tradito i valori fondamentali condivisi con l’America, a partire da una libertà di espressione «in ritirata». Terzo indizio: se, citando ancora Vance, è «importante, nell’ambito di un’alleanza comune, che gli europei si facciano avanti mentre l’America si concentra su aree del mondo in grave pericolo», la possibilità che gli Usa ritirino truppe e basi militari dal Vecchio Continente è concreta. In effetti, su un bilancio generale di 814 miliardi di dollari e una forza globale di 3,4 milioni di militari, Washington ha sempre dato una certa rilevanza all’Europa che, però, riflette ancora l’esito della seconda guerra mondiale. Su 65.600 militari americani in Europa, oltre 34.000 sono in Germania e oltre 12.000 in Italia, ossia nei due Paesi sconfitti nel 1945. Lo stesso vale per le basi militari: su 37, 13 sono in Germania e 7 in Italia. Allo stesso tempo, Washington non ha mai nascosto la necessità di privilegiare scenari ben più strategici come l’Indo-Pacifico, necessario per valorizzare i Five Eyes — l’alleanza con Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Canada — e per contrastare la Cina, principale antagonista dell’egemonia americana.
Il cambio di paradigma americano non è cosa nuova, ma ora l’amministrazione Trump lo sta rendendo concreto sia per sostenere il primato americano — «make America great again» — sia per mettere in atto lo slogan «America first», tanto caro a quella corrente intellettuale statunitense fatta di conservatori, populisti e reazionari spesso sottovalutati da accademici ed editori stranieri.
Per colmare l’abisso transatlantico, l’Europa, allarmata sia sul piano geopolitico sia su quello economico a causa degli annunciati dazi, sta ora correndo ai ripari. Entro questa dimensione va interpretata tanto la conferenza sull’Ucraina voluta da Macron quanto la risposta del cancelliere tedesco a Vance. Sempre a Monaco, Olaf Sholz si è detto certo di «aver creato istituzioni che rendono le nostre democrazie difendibili dai loro nemici e regole che non limitano la nostra libertà, ma la proteggono. Difendere la libertà e la democrazia contro i loro nemici è ciò che ci unisce da sempre come comunità transatlantica e che ci unisce anche oggi».
Eppure, le nobili ambizioni europee devono fare i conti con la realtà: ad oggi non sembra esserci un leader capace di mettere in pratica quanto promesso. Gli innumerevoli paradossi europei lo dimostrano. Uno Stato membro, l’Ungheria, ha addirittura bocciato l’iniziativa francese dicendo che essa «blocca gli sforzi per la pace», mentre altri hanno lamentato l’assenza di tutti i 27 Paesi.
Così, al di là delle faglie interne a Francia e Germania, dove è sempre più difficile governare, il vero protagonista del vertice di Parigi sembra essere il Regno Unito — unico Paese ad essere uscito dall’Ue —, il cui primo ministro Keir Starmer si è detto «pronto ad inviare truppe in Ucraina».
E se il Vecchio Continente teme che i venti contrari da Oltreoceano possano alimentare l’instabilità interna, Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea ed ex primo ministro italiano, sul «Financial Times» ha scritto un editoriale significativamente intitolato “Dimenticatevi degli Stati Uniti: l’Europa i dazi se li è autoimposti”. Draghi cita il Fondo monetario internazionale, secondo cui «le barriere interne all’Europa equivalgono a una tariffa del 45 per cento per la produzione e del 110 per cento per i servizi» che «riducono di fatto il mercato entro cui operano le aziende europee». Allo stesso modo, Draghi nota come l’eccesso di regolamentazione «ostacola la crescita delle aziende tecnologiche e impedisce all’economia di guadagnare sbocchi di produttività».
Si pensi, poi, alle differenze nei costi energetici tra Paesi Ue: a gennaio in Italia il prezzo medio dell’elettricità era di 143 euro al MWh, il 25 per cento in più rispetto alla Germania, il 40 per cento in più rispetto alla Francia, il 48 per cento in più rispetto alla Spagna e il 226 per cento in più rispetto ai Paesi scandinavi. Oppure, al settore dell’acciaio, dove la tassa carbonica ha fatto lievitare i costi per i produttori, e all’automotive, dove Bruxelles ha imposto normative stringenti per raggiungere obiettivi climatici senza tenere conto né delle materie prime necessarie né dei costi sociali per applicare simili cambiamenti in così poco tempo.
Con la burocratizzazione dei processi di decisione e col culto della tecnocrazia, l’Europa ha sì sviluppato una cultura della regolazione, ma ha dimenticato la cultura della produzione. Che è linfa vitale per stimolare l’iniziativa, per mantenere alto il consenso sociale, per rendersi attrattivi, quindi per non diventare preda altrui.
L’Osservatore Romano – 17/2/2025