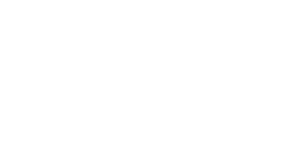Situata al centro del Sudan, a circa 130 chilometri dalla capitale Khartoum, principale città dello stato di Gezira, snodo logistico, polo commerciale e agricolo, nei primi giorni del conflitto scelto come rifugio dagli sfollati: sono queste le caratteristiche principali di Wad Madani, la città riconquistata lunedì dall’esercito sudanese dopo oltre un anno di occupazione da parte delle Forze di supporto rapido (Rsf), guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemetti.
«Il solo fatto che la notizia sia stata confermata da entrambe le parti in guerra è quasi un inedito», dice Luciano Pollichieni, analista della Fondazione Med-Or, parlando al nostro giornale: «Il conflitto in Sudan è quello in cui circolano più notizie false al mondo. Ambientarsi è quindi difficile. Tuttavia, dal punto di vista tattico è chiaro che la riconquista di Wad Madani ha un certo valore per l’esercito sudanese. Questo snodo si collega attraverso un’autostrada a Khartoum, la capitale su cui l’esercito sta concentrando i suoi sforzi. Tuttavia, sul piano strategico, quindi su chi vince tra le parti in guerra, questa notizia conferma un certo stallo. Da un lato, l’esercito è impegnato ad avanzare in ogni modo verso Khartoum per paura che Hemetti possa ergersi a governante del Sudan. Dall’altro lato, le Rsf perdono sì terreno ma continuano a spadroneggiare nelle regioni occidentali, in particolare nel Darfur, dove sembrano voler creare un’entità geopolitica e istituzionale separata dal resto del Paese».
Proprio nel Darfur settentrionale i paramilitari hanno recentemente conquistato la base logistica di al-Zurug, strategica per incanalare i rifornimenti provenienti dal Ciad e dalla Libia. Sempre nella stessa area, lunedì almeno 16 persone sono morte e altre 42 sono rimaste ferite in un attacco al campo profughi di Zamzam, a El Fasher. Come riferito dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), «in soli cinque giorni, tra le mille e le tremila famiglie sono state sfollate dalla città di Umm Ruwaba», la seconda città più grande del Kordofan settentrionale, regione fondamentale per la sua vicinanza alla capitale.
Ecco come si alimenta la più grande crisi di sfollati al mondo. In Sudan almeno 11,5 milioni di persone sono costrette a fuggire, mentre i morti sfiorano quota 26.000. A pesare non è solo il conflitto scoppiato nel 2023 tra il capo dell’esercito Abdel Fattah al-Burhan e il suo ex vice Hemetti. Ben 2,7 milioni di persone sono state costrette a fuggire a causa di guerre precedenti. Si pensi al conflitto in Darfur, datato 2003 e avviato da ribelli che hanno accusato il governo di sostenere le milizie Janjaweed. Dal 2011 regioni di confine col Sud Sudan e l’Etiopia come il Kordofan meridionale e il Blue Nile alimentano movimenti indipendentisti. Ai tre colpi di Stato in quattro anni, con cui è stato destituito il presidente Omar al-Bashir, va poi aggiunta la precarietà dell’intera area, che passa per il Sahel — in Paesi come Niger, Ciad e Mali i golpe militari hanno peraltro spazzato via la presenza francese — e per il Nord Africa — toccando in particolare la Libia.
Almeno 3 milioni di sfollati sudanesi cercano riparo nei Paesi confinanti, portandosi però dietro malattie e carestia. Secondo il Global Hunger Index, in Sudan oltre 25 milioni di persone affrontano la fame estrema, l’11,4 per cento della popolazione è denutrita e il 39,6 per cento dei bambini sotto i cinque anni soffre di rachitismo. Da oltre venti mesi gli studenti non hanno accesso all’istruzione.
Tutt’altro che isolata, questa guerra si conferma parte della «terza guerra mondiale a pezzi» più volte descritta da Papa Francesco. Essa coinvolge potenze come la Russia — che nel Sudan vede una pedina per il controllo delle rotte commerciali e militari del canale di Suez e dello stretto di Bab el-Mandeb — e gli Stati Uniti — la scorsa settimana il presidente Joe Biden ha detto che in Sudan è in corso un «genocidio» e ha avviato sanzioni contro le Rsf, ma molto dipenderà dalla nuova amministrazione Trump. Così il 2025, per un Paese tanto importante quanto fragile, si preannuncia un anno ben peggiore di un già orribile 2024.
L’Osservatore Romano – 14/01/2025